NAPOLEONE COLAJANNI DEMOCRAZIA E MASSONERIA
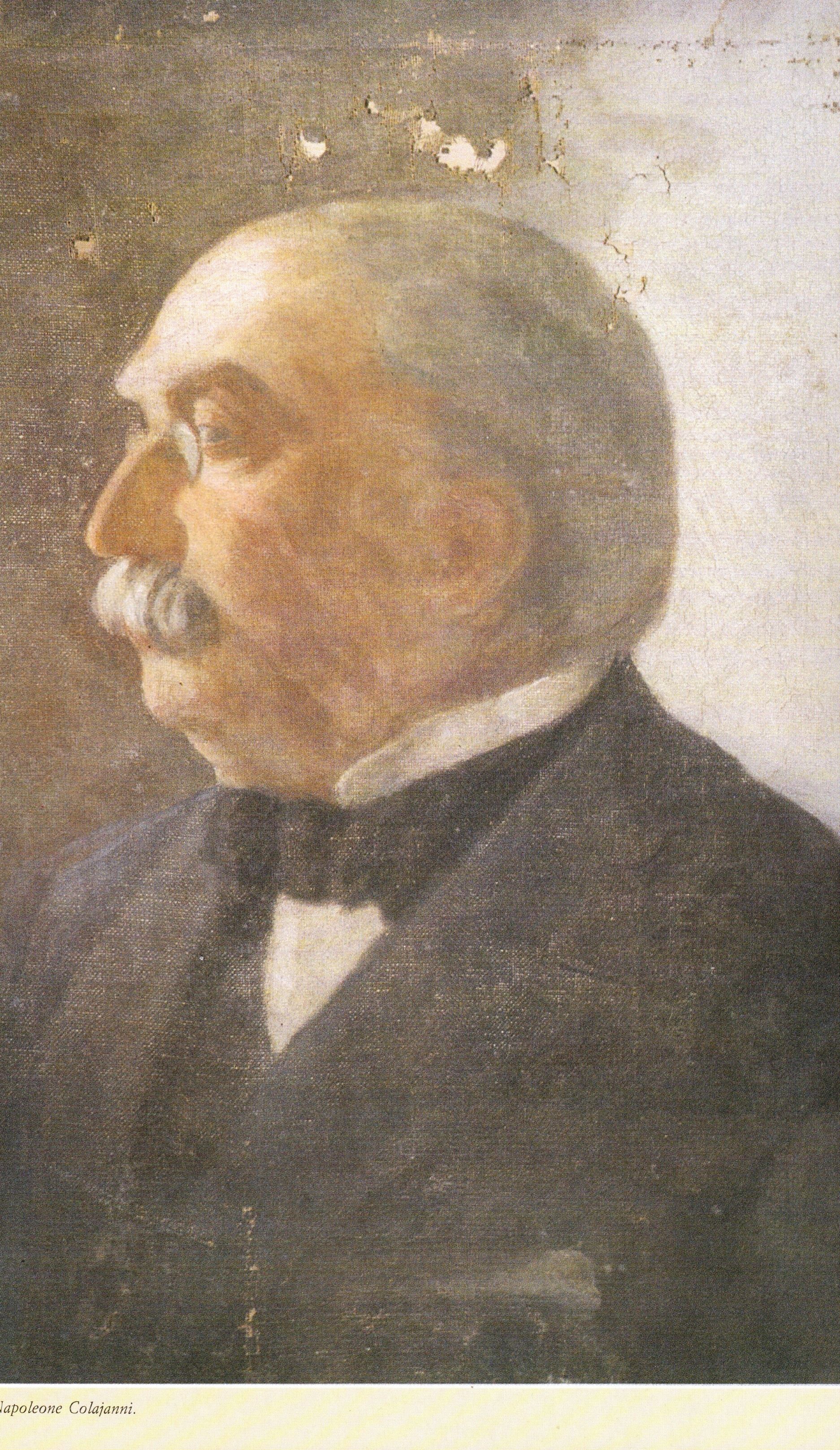
“Libero massone, in libera loggia”
Napoleone Colajanni (Castrogiovanni, dal 1927 tornata Enna, come nell'antichità, 28 aprile 1847-2 settembre 1921) è stato tra i politici più importanti della Nuova Italia. Repubblicano senza fanatismi, socialista al di fuori degli schemi, meridionalista libero da paraocchi, è al centro dell'attenzione storiografica. Giunge ora in libreria un'ampia antologia di suoi articoli e saggi, curata dal professor Francesco Luigi Oddo e pubblicata da BastogiLibri (Roma) per iniziativa della Libera Università “Tito Marrone” di Trapani, presieduta dal professor Antonino Tobia e animata da Vincenzo Vitrano. L'opera non è un generico invito a riscoprire uno dei principali protagonisti della lotta politica per l'avvento e il consolidamento dell'unità d'Italia, ma, forte di introduzioni e di un accurato apparato critico, conferma l’attualità della sua figura. Il volume documenta che, più di un secolo dopo la morte, Colajanni parla dei problemi odierni dell'Italia e di una “Europa” ancora “in fieri”, alle prese con guerre, in corso e potenziali, alleanze difensive fragili, a geometria variabile, fatte di accordi palesi e di clausole ignote alla generalità dei cittadini. Ai suoi tempi le grandi “questioni” del pianeta erano affrontate e risolte nello steccato dei rapporti niente affatto lineari tra gli Stati europei, gli altri continenti e i loro popoli. Cent'anni dopo, la geografia continua a dettare la storia. I principi etici e giuridici di allora incalzano pressoché invariati, in attesa di soluzioni sempre meno probabili per l'assenza di istituzioni sovrastatuali universalmente accettate: in passato lo furono la Corte dell'Aja e la Società delle Nazioni, da ottanta anni lo sono l'ONU e, di seguito, i Tribunali internazionali. La differenza netta tra l'atlante geo-politico di riferimento di Colajanni e il presente sta nel fatto che fra Otto e Novecento l'“Europa” andava dall'Atlantico a Vladivostok, mentre ora si sfalda sull'incerto “limes” tra la Germania e la Federazione delle repubbliche russa. Al tempo suo non esistevano né Polonia né Ucraina, né, meno ancora, gli staterelli baltici. Il Vecchio Continente si affacciava, all’epoca, su un Mediterraneo quasi completamente controllato dalle grandi potenze continentali, nell'ormai manifesto declino dell'impero turco-ottomano, il “grande malato d'Oriente”. L'Europa odierna, invece, vede in atto vari conflitti armati, dalla Libia al Vicino Oriente. È un bacino solcato da flotte navali e aeree di Stati extraeuropei, in allarme perpetuo. Inoltre, a differenza di quanto oggi accade, le relazioni tra gli Stati dell'Europa centro-occidentale e l'altra sponda dell'Atlantico ai tempi di Colajanni non avevano quale referente pressoché esclusivo o quanto meno prevalente gli Stati Uniti d'America o l'America Settentrionale, ma le “tre Americhe”, con molta attenzione per quella Centrale, mentre si stava lavorando ad aprire il Canale di Panama. All'epoca tale tripartizione era nettamente configurata. Di quei “mondi” Colajanni aveva cognizione personale e indiretta, continuamente aggiornata sia attraverso la lettura sistematica di riviste e quotidiani d'Oltralpe e d'oltre Oceano, sia tramite quanto se ne apprendeva dalla viva voce e dal carteggio della moltitudine dei migranti. I decenni centrali del suo magistero politico, va ricordato, coincisero con la “grande migrazione” che, iniziata dalle regioni settentrionali, investì il Mezzogiorno, soprattutto dopo che Roma si era vista precludere l'approdo in Tunisia, ritenuto “naturale” sino a quando, nel 1882, Parigi impose il suo protettorato al bey di Tunisi. Tra gli aspetti meno noti della vita di Colajanni vi è il suo rapporto con la Massoneria. Massimo Ganci, storico rigoroso e competente, non ne fa alcun cenno nel “Dizionario biografico degli italiani”, se non col rinvio, in biliografia, a una nota Storia della Massoneria in Italia” (Bompiani, 1976). Il profilo pubblicato nel “Dizionario del movimento operaio e socialista” lo ignora. Ne scrive, invece, Francesco Renda nell'ampio profilo di Colajanni per “Il Parlamento Italiano”,vol. VII, 1902-1908, (Nuova CEI, Milano, 1990). A suo ponderato avviso, i contrasti sul sistema bancario dell'ultimo decennio dell'Ottocento tra Colajanni, Vilfredo Pareto e Maffeo Pantaleoni da un canto e Giovanni Giolitti e, ancor più, Francesco Crispi dall'altro, come poi tra Colajanni lui e Antonio Starrabba di Rudinì, vanno campeggiati anche nell'ambito del compagnonaggio massonico, intessuto di dissensi e conflitti assai più che di fratellanza. In “La massoneria nel parlamento. Primo Novecento e fascismo” Luca Irwin Fragale osserva che «non è poi sufficiente il telegramma del Gran Maestro Torrigiani al prof. Emanuele Cecconi in occasione della morte di Napoleone Colajanni [1921, NdA] per attestare l'appartenenza di quest'ultimo al GOI, altrove affermata». Invece l'appartenenza di Colajanni alla Massoneria è assolutamente certa, così come sono provati i suoi continui contatti con eminenti “fratelli” del suo tempo. Abbiamo alcuni punti fermi. In effetti (ma è un “caso” relativamente comune, data la dispersione degli archivi di logge che nascevano e morivano), non vi è traccia della sua iniziazione né della sua asserita affiliazione alla loggia “I figli dell'Etna” Però si può affermare con assoluta certezza la sua appartenenza al Grande Oriente d'Italia (GOI). Essa è documentata dalla lettera di “vivace polemica” che nel 1877 Ulisse Bacci indirizzò al “F∴ Colajanni” dalle colonne della “Rivista della Massoneria italiana”, di cui era direttore e proprietario. Ribaditi i “vincoli di fraterna amicizia”, Bacci lo invitò a non rinvangare il passato («non andiamo a vedere chi abbia maggiormente contribuito all'unione del 1872, e neanche chi abbia scritto nel 1877 con maggior vivacità, ma stringiamoci da fratelli la mano, e “viribus unitis” scendiamo a combattere il comune avversario». Bacci aggiunse di averlo ritenuto «sempre Massone convinto e sincero». Perciò sarebbe stato «lietissimo di potergli stringere la destra in Roma, e di mostrargli coi fatti la “sua” stima e la “sua” fraterna affezione». «Veda dunque il F∴ Colajanni – aggiunse – che non vi è bisogno di uscire dal Tempio; ma vi è invece necessità di restarvi per impedire che c'entrino coloro che ne sono indegnissimi.» L'uso appropriato del cifrario massonico da parte di Bacci dissipa ogni dubbio. L'invito a non uscire dal Tempio chiude il cerchio.
La Massoneria? Un gran disordine e un gran tramestio.
Nel “Libro del Massone italiano”, troppo a lungo sottovalutato, Bacci ricordò gli eventi del 1872 e del 1877 richiamati nella lettera a Colajanni. L’Assemblea Costituente massonica romana del 1872, dopo «discussioni assai scomposte e qualche volta tumultuose», accorpò nel GOI «vari gruppi esistenti fino allora», ovvero i “comitati” di Napoli, Bari, Palermo e le “logge dissidenti”, capeggiate dal mazziniano Federico Campanella. A frenare l'unità effettiva dell'Ordine liberomuratòrio in Italia concorsero le distinzioni dei massoni del GOI in tre diversi riti: (simbolico, “francese” di sette gradi, che risultava il più noto e praticato, e il Rito scozzese antico e accettato di 33 gradi) mentre il Supremo consiglio di Washington riconosceva quello sedente in Torino e si moltiplicavano gruppi massonici indipendenti, come la “Sicilia”. «Insomma – osservò Bacci, carte alla mano – un gran disordine e un gran tramestio.» Dopo l'ascesa della Sinistra al governo (marzo 1876) il rovello all'interno delle file massoniche italiane divenne ancora più lacerante. Esso nasceva dalla ricerca di “equilibri più avanzati”, perché la Massoneria aveva molti esponenti al governo del Paese e, quindi, al fianco della Corona (Agostino Depretis, Giovanni Nicotera, Alfredo Baccarini, Michele Coppino...). Però l'Ordine non rinunciava a contare al proprio interno mazziniani, garibaldini, radicali, federalisti e simpatizzanti per l'Internazionale protosocialista. Conciliava responsabilità nel presente e proiezione verso un futuro indeterminato nei tempi di realizzazione ma non indefinito negli obiettivi. A complicare il quadro concorreva il rapporto tra la Massoneria e il “Libero Pensiero”, una corrente carsica che, per influenza francese, percorse il Paese dagli Anni Sessanta a inizio Novecento. Erano inevitabilmente relazioni difficili, perché i liberi pensatori rifiutavano non solo qualsiasi religione rivelata ma anche tutti i simboli religiosi, mentre la Massoneria conservò sempre la formula iniziatica “Alla Gloria del Grande Architetto dell'Universo”, caposaldo di un sia pur vago deismo.
Un massone nell'arena della “politica”
Nel 1882, l'anno della morte di Garibaldi e del progetto di un Congresso massonico internazionale volto a studiare il modo migliore col quale la donna potesse partecipare al lavoro massonico, Colajanni fu eletto consigliere comunale. Dieci anni dopo entrò nel consiglio provinciale. Era il tirocinio ordinario per chi, come lui, ambiva a esercitare il ruolo nazionale non solo attraverso gli scritti ma anche in Parlamento in un'età di importante produzione legislativa. Sin dal 29 ottobre 1882 egli si era candidato alla Camera nel collegio di Caltanissetta. Le votazioni si svolsero in collegi plurinominali (in quel caso comportavano quattro seggi) e scrutinio di lista. Con 2.268 preferenze Colajanni risultò il quarto degli esclusi. Il 23 maggio1886, con 5.024 voti, fu invece il primo dei perdenti. Il 23 novembre 1890, infine, venne eletto con 7.469 preferenze, terzo di una lista comprendente il conte Ignazio Testasecca, Domenico Minolfi e Vincenzo Riolo. Col ritorno ai collegi uninominali, il 6 novembre 1892 Colajanni vinse senza competitori nel “suo” collegio di Castrogiovanni, che gli rinnovò il seggio sino al 1919, vennero introdotti il suffragio universale maschile e il riparto proporzionale dei seggi e fu comunque confermato. Alle elezioni del 7 maggio 1909 fu rieletto con 1.624 voti su 2.982 elettori e in due successive riconvocazioni del collegio per sue dimissioni venne confermato. Altrettanto accadde il 26 ottobre 1913, quando, senza rivali di sorta, ottenne 5.896 preferenze su 16.589 iscritti alle liste elettorali. La massoneria concorse alla sua ascesa nella vita politica locale e nazionale? In carenza di documenti, il quesito rimane senza risposta. Nell'arco dei trentacinque anni dal suo ingresso alla Camera il nome di Colajanni non affiora da alcuna cronaca di vita massonica. Non compare né nelle riviste del GOI, né in eventi culturali e politici fiancheggiati da istituzioni liberomuratòrie. Di sicuro, come emerge dalla sua vasta produzione saggistica e dall'antologia curata da Francesco Luigi Oddo, Colajanni si confrontò personalmente con politici notoriamente massoni, ma non esitò a combatterli apertamente quando lo ritenne doveroso. Valgano ad esempio le battaglie da lui combattute contro i suoi conterranei Francesco Crispi e Nunzio Nasi. Di quest'ultimo scrisse e ripeté che, condannato sia pure per un reato di modesto rilievo, non poteva essere sindaco, ovvero “pubblico ufficiale”. Il suo originario “massonismo” risulta dunque paradigmatico. Da un canto indica che nei primi anni dell'unità nazionale l'ingresso in loggia era “normale” per giovani militanti della Sinistra (a vent'anni Colajanni aveva già messo alle spalle varie “patrie battaglie” nelle file garibaldine), dall'altro prova che esso non comportò vincoli di dipendenza nell'esercizio del mandato elettivo, più di quanto derivasse da convergenze propriamente culturali e politiche. L'uomo apprendeva dalla loggia ma rappresentava sia gli elettori sia quanti non avevano diritto di voto, ed erano i più. Lo conferma il ruolo svolto da Colajanni in momenti di drammatica crisi politica, dai “Fasci siciliani”, studiati a fondo da Salvatore Costanza, alla scelta pro o contro l'intervento dell'Italia nella Grande Guerra e a fronte dell'onda rivoluzionaria postbellica. Ogni volta il repubblicano, federalista e protosocialista Colajanni si mostrò incline alla mediazione, che non significa compromesso ma valorizzazione delle istituzioni per frenare il precipizio verso scontri sanguinosi e la militarizzazione dei pubblici poteri a danno dei cittadini. Il suo limpido laicismo non gli impedì di apprezzare monsignor Isidoro Carini. Del pari, l'opzione repubblicana non fece velo alla prospettiva che la monarchia evolvesse verso l'approdo democratico senza traumi. Non solo per ciò attestò pubblicamente la sua stima, ricambiata, nei confronti di Vittorio Emanuele III, re costituzionale e garante dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi.
Tra le quinte della “politica”
Parlamentare di lungo corso, medico chirurgo – “missione” che praticò a beneficio dei poveri –, docente universitario di statistica e poligrafo di fama europea, Colajanni vide con lucidità la condizione del deputato, spesso sospinto dalla “vis a tergo” dell'elettorato e meno autonomo di come narrato dalla leggenda antiparlamentare che lo dipingeva capofila di clientele e voltacasacca per calcolo personale anziché, come avveniva, per una sorta di “ricatto di massa” esercitato dai votanti nei suoi confronti. Al riguardo Colajanni fu lapidario: «Le masse applaudiscono indifferentemente chi sale e chi scende.» Democratico integrale (evocatore del Patto di Roma ed estimatore del pugnace e intrepido Felice Cavallotti), Colajanni si pronunciò controcorrente su questioni che all'epoca costituivano vessillo delle sinistre. Fu il caso del voto politico femminile, osteggiato da lui come da Giovanni Giolitti, che egli reputò personalmente onesto ma politicamente cinico. Proprio come lo statista piemontese, che nel 1902 non esitò a militarizzazione i ferrovieri per impedir loro di scioperare, anche Colajanni deplorò il diritto di sciopero degli impiegati pubblici, “operatori” dello Stato, tenuti a prestare servizio nel superiore interesse dei cittadini. Tra i suoi meriti maggiori di meridionalista vi fu la netta contrapposizione a Cesare Lombroso, che attribuiva l'arretratezza del Mezzogiorno a fantasiosi “fattori congeniti”. Al tempo stesso confutò chi la faceva datare dall'unificazione nazionale e la imputava all'ingordigia del Nord: polemica decenni addietro reiterata dal neomeridionalismo e dalle sue varianti, incluso il neoborbonismo. Poiché aveva radici quasi bimillenarie, la somma di arretratezza e sottosviluppo per essere corretta richiedeva riforme profonde, fondate sulla cognizione scientifica della realtà, e il coraggio dell'impegno sui tempi lunghi, senza illusioni miracolistiche. Altrettanta cautela pose a cospetto del partito socialista italiano, che gli parve debitore verso una “dottrina”, anziché volto a obiettivi perseguibili in tempi ragionevoli e con esiti positivi. Prosatore efficace e oratore trascinante, Colajanni rifuggì dagli slogan e dai comizi. Predilesse il ragionamento, pronto anche a mutare consiglio su questioni, come la protezione doganale, che altri risolvevano in termini dottrinali o “di principio”. Perciò in tempi diversi risultò antiprotezionista e “protezionista condizionato”.
Patriota contro il bolscevismo
Il vortice della Grande Guerra investì anche Colajanni. Come molti interventisti e come Antonio Salandra e Sidney Sonnino, i due maggiori responsabili dell'ingresso dell'Italia in guerra, ignari della complessità del conflitto, anche Colajanni sull'inizio non escluse che la conflagrazione potesse terminare entro il 1915. Elencò le «previdenze» che il governo avrebbe dovuto curare e costatò che non erano state tenute in conto. Di seguito si scagliò con toni inusitati contro la «barbarie tedesca». Incitò a «temere, evitare, odiare i tedeschi»: parole gravi. Nel dopoguerra fu coerente con la scelta iniziale: difese le “ragioni” dell'intervento, ma senza indulgenza per le mire del governo sulla Dalmazia, ove semmai andava incoraggiata, la migrazione pacifica, sulla traccia di insediamenti di italofoni. Bisognava evitare di gettare semi di conflitti futuri. Altrettanto comprensibile risulta la sua polemica nei confronti della “diserzione” della Russia dalla guerra (essa consentì agli Imperi Centrali di dirottare le loro forze su fronte italiano, più vulnerabile di quello francese), del regime bolscevico e di quanti in Italia proclamavano di voler “fare come in Russia”. Gli articoli del 1919-1920 mostrano che Colajanni era in sintonia con il vasto arco di forze poi raccolte da Giolitti nei blocchi per le elezioni amministrative del novembre 1920 e, per la quinta volta presidente del Consiglio, in quelle per il rinnovo anticipato della Camera nel maggio 1921. Quei blocchi andavano dai liberali di varia ascrizione ai combattenti, dagli agrari ai “democratici”, dagli ex socialriformisti ai fascisti, il cui programma politico prese forma solo quando il movimento divenne partito, nel novembre 1921. A quel punto Colajanni era già passato all'Oriente Eterno. Si comprende che il gran maestro Domizio Torrigiani abbia espresso il cordoglio dell'Ordine per la scomparsa di chi «alla Massoneria italiana» aveva dato «da giorni lontani operosa fede e fino alla morte illuminata cooperazione». In quei frangenti, dopo avere inizialmente promosso e attizzato l'avventura di Gabriele d'Annunzio a Fiume e mentre cercava di massonizzare il nascente fascismo quale argine contro i socialisti e il partito popolare italiano, che minacciava la laicità dello Stato, anche il GOI era lontano dall'individuazione di una linea chiara. Ne hanno scritto recentemente Luca G. Manenti e Fulvio Conti. Nell'Assemblea del 1920 Torrigiani si spinse a mettere in discussione la forma dello Stato. Quanto alla polemica con le sinistre rivoluzionarie, va ricordato che esse erano state bersaglio dei roventi articoli di Ernesto Nathan nella “Nuova Antologia” contro l'insidioso contagio delle parole: il “bolscevismo”. Solo sei anni dopo divenne chiara l'incompatibilità tra valori fondanti (elettività e temporaneità delle cariche e libertà della politica) e pulsioni totalitarie insite nel fascismo, come documenta il volum “1925.Vrso il regime” (Bastogilibri, 2025). Ma ormai era tardi. Dopo la morte, Colajanni fu spesso strumentalizzato o marginalizzato. L'antologia curata da Luigi Francesco Oddo lo restituisce nella sua complessa genuinità.
Aldo A. Mola
DIDASCALIA: Napoleone Colajanni. Nella Premessa al volume “Note autobiografiche e considerazioni politiche” di Napoleone Colajanni, Antologia curata da Francesco Luigi Oddo per le edizioni BastogiLibri (Roma), il prof. Antonino Tobia, presidente della Libera Università di Trapani “Tito Marrone”, validamente fiancheggiato da Vincenzo Vitrano, pubblica l' Albo d'Oro, elenco delle centinaia di Relatori che da tutta l'Italia si sono onorati di svolgervi lezione. Tra i molti spiccano Antonio Baldassarre, già presidente della Corte costituzionale, Ugo Intini, Domenico Mogavero, i vescovi di Trapani e di Mazara del Vallo, Marziano Pagella, storico dell'architettura, il magistrato Pietro Pellegrino, Paolo Ricca dell'Università Valdese di Roma, l'archeologo piemontese Dario Seglie, l'antropologo senese Vinicio Serino, l'arpista Elena Zaniboni e il senatore Valerio Zanone: una “catena di unione” ispirata dallo spirito civile di Napoleone Colajanni.