PIÙ LUCE A OCCIDENTE
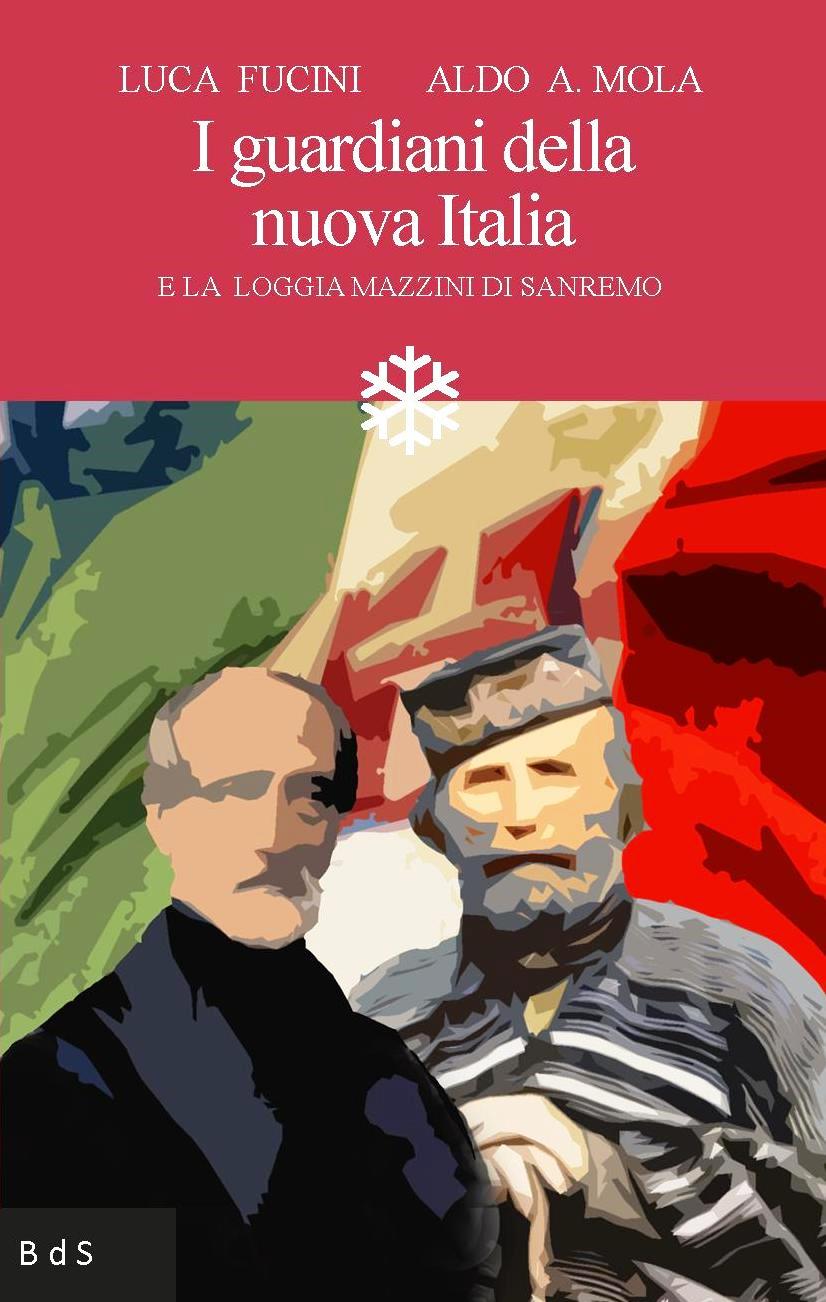
Si svolgeranno nelle prossime settimane rievocazioni del contributo dei massoni italiani al radicamento dei princìpi enunciati dalla Costituzione dello Stato d'Italia: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (…) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Particolare attenzione richiamano i convegni in programma in Liguria, a cominciare da Sanremo, nel 125° della fondazione della Loggia intitolata a Giuseppe Mazzini /4 maggio). lI 31 maggio sarà la volta del 125° della “Giuseppe Garibaldi” di Imperia.
1898: quando Roma ruppe con Parigi
Nel 1898 il Grande Oriente d'Italia (GOI) visse la prima severa crisi dopo la sua faticosa nascita (1859-1864) e la lenta fusione in un'unica “Famiglia” di vari corpi massonici grazie alla tenace opera di Adriano Lemmi, gran tesoriere dell'Ordine, gran maestro aggiunto e gran maestro dal 1885 al 1896. Alla morte di Felice Cavallotti, “bardo della democrazia”, trafitto alla gola da Ferruccio Macola il 6 marzo 1898 nel suo 33° duello e compianto dai massoni benché non fosse “iniziato”, nel volgere di pochi mesi passarono all'Oriente Eterno il giurista Giuseppe Ceneri, membro della “Propaganda massonica”, e due tra i più prestigiosi pionieri della rinascita massonica in Italia, Felice Govean, fondatore della “Gazzetta del Popolo”, e David Levi, drammaturgo, più volte deputato e alto dignitario del Rito scozzese antico e accettato. Nell'anno che doveva festeggiare il mezzo secolo dello Statuto Albertino e rimane invece in memoria per la proclamazione dello stato d'assedio e per la sanguinosa repressione dell'“insurrezione” a Milano, Pavia, Livorno e La Spezia, varie logge e nuclei di “fratelli” si separarono dal GOI, costituendosi dapprima in Federazione indipendente massonica italiana, poi in Grande Oriente Italiano, nome originariamente assunto dalla comunità liberomuratòria alla sua nascita, nel 1859-1862. La scissione non fu né imprevedibile, né improvvisa. Da tempo cresceva la tensione di massoni delusi da Ernesto Nathan, successore di Lemmi alla gran maestranza. Anziché imprimere alla comunità la svolta “democratica” da molti attesa, Nathan sembrava muoversi nel solco del predecessore. Eppure proprio lui ed Ettore Ferrari, scultore celebre per molte opere di impronta anticlericale, come il “Giordano Bruno” scoperto nel 1889 in Campo dei Fiori a Roma, “ove il rogo arse”, avevano costretto Lemmi alle dimissioni. Amareggiato ma sicuro di sé, questi era rimasto sovrano gran commendatore del Rito scozzese, il Corpo che aveva generato il Grande Oriente. Messo sull'avviso dall'attivismo di “dissidenti” e sospettando che essi fossero eterodiretti da Oltralpe, il 10 giugno 1897 Nathan invitò il gran maestro del Grande Oriente di Francia (GOF) a diffidare di chi dall'Italia si presentasse senza le necessarie credenziali del GOI. Il capo della segreteria generale del GOF gli rispose per conto del gran maestro, limitandosi a ringraziare per la “fraterna comunicazione”. Il 21 febbraio 1898 la Commissione delle relazioni esterne del GOF riconobbe il Grande Oriente Italiano come “potenza massonica regolare”. Il 4 marzo 1898 Nathan chiese ad Armand Croissant, garante d'amicizia del GOI presso il GOF stesso, di fornire a Parigi le informazioni sull'irregolarità dei dissidenti. Dopo ulteriori schermaglie epistolari, a cospetto dell'avvenuto riconoscimento del milanese GO Italiano da parte di Parigi senza previa consultazione di Roma, il 24 aprile 1898 il GOI deliberò la rottura “di ogni relazione col GOF e con le logge che ad esso prestano obbedienza”: una decisione traumatica, sia per la disparità numerica tra le due comunità, sia per la differenza del loro peso politico agli occhi dei governi dei rispettivi Paesi. Mentre in Francia la Repubblica si interfacciava continuamente con il GOF, in Italia il Re ufficialmente ignorava il GOI, per non esasperare papa Leone XIII e il movimento clericale. Il GOF venne dunque imputato di essere il regista della dissidenza, della secessione e della costituzione in Italia di un nuovo Grande Oriente, un evento di portata “politica” assai più che iniziatica. La fondazione di una “potenza” nei confini di uno Stato nel quale già era sovrano un Ordine legittimo e regolare costituiva infatti un’insopportabile violazione delle regole massoniche proclamate e osservate, sull'esempio della Gran Loggia Unita d'Inghilterra, che le predicava ma vi ottemperava solo dove le faceva comodo. Non occorreva però memoria lunga per non vedere nella manovra di Parigi il colpo di coda della lunga avversione mostrata dal GOF contro il triangolo massonico italiano: Adriano Lemmi-Francesco Crispi-Giosue Carducci.
L'Ordine e lo Stato nella tensione internazionale
La risposta del GOI ai dissidenti e ai “fratelli” d'Oltralpe venne affidata alla circolare 18 aprile 1898 con cui Nathan richiamò le logge italiane a «maggiore compattezza e maggiore senso di responsabilità nell'adempiere a tutti gli uffici cui l'Istituzione deve intendere per rispondere ai suoi fini ed ai bisogni della Nazione». Il divario tra GOI e GO Italiano non era solo nominalistico ma riguardava il loro rapporto con “la Nazione” ovvero, più correttamente, con lo Stato d'Italia. Sin dalla sua costituzione il Grande Oriente parigino si era identificato con “la Francia”, quali ne fossero la forma (monarchia, repubblica, impero, nuovamente repubblica...), i capi di Stato e i governi. Invece il Grande Oriente d'Italia non si era mai esplicitamente riconosciuto né nel Regno (di Sardegna prima, d'Italia poi), né nella Casa di Savoia e nei suoi sovrani, anche se a loro era rivolto il primo brindisi nelle agapi fraterne. David Levi aveva ripetutamente messo in guardia dal rischio di ricalcare il modello britannico, che aveva per gran maestro il re o il suo prossimo congiunto. L'opzione monarchica in Italia era rimasta sotto traccia per propiziare l'unificazione dei corpi massonici, in gran parte mazziniani o “garibaldini”. Il mosaico non resse alle tensioni tra interessi statuali, inclusa la politica coloniale in diretta competizione con la Francia, e alle mai sopite divisioni all'interno dell'Ordine fra monarchici da un canto, repubblicani e federalisti dall'altro. Lo documentavano gli stessi nomi distintivi delle logge. Mentre non ne mancavano di intitolate a Mazzini o a Carlo Cattaneo nessuna ricordava Vittorio Emanuele II, a tacere, s'intende, di Carlo Alberto, “assolto” da Carducci nell'Ode “Piemonte” e poi celebrato dal massone Giovanni Pascoli quale “Re dei Carbonari”. La crisi della Massoneria italiana a fine Ottocento va inquadrata nel contesto politico-militare euro-americano in cui maturò. Nel 1898 Francia e Gran Bretagna giunsero sull'orlo di un conflitto armato per il dominio coloniale a Fashoda, un punto strategico sul corso del Nilo. Ognuno dei due governi chiamò a raccolta tutte le energie che dovevano riconoscersi nelle fortune dei rispettivi Stati. Il GOF fece quadrato in difesa della Repubblica, lacerata dall'“affaire” dell'ufficiale ebreo Alfred Dreyfus (non massone, come ricordò la “RMI”) accusato di alto tradimento, degradato e condannato a pena severissima. Lo stesso anno la rivolta eterodiretta dagli USA a Cuba e nelle Filippine contro Madrid chiarì che il primato degli Stati aveva la priorità sulla fratellanza tra i popoli. In quella temperie, in Italia le propensioni verso le autonomie vennero deprecate come dissidenze e focolai di disgregazione: quinta colonna del nemico. Quale? Per via dell'alleanza del 1882 con Berlino e Vienna, sua antagonista storica, e della politica coloniale, sgradita a tutte le potenze, l'Italia non aveva né veri alleati, né, meno ancora, amici. Il 6 maggio 1898 Nathan fulminò la “ribellione” dei “gruppi irregolari” con l'espulsione di quanti si riconoscevano nel Grande Oriente Italiano con sede a Milano, sotto la direzione del deputato radicale Malachia De Cristoforis e, come già aveva fatto Ludovico Frapolli nel 1867 ai danni degli affiliati alla loggia “Felsinea”, tra i quali Carducci, ne pubblicò i nomi nella “Rivista della Massoneria Italiana” (RMI), consapevole che questa finiva anche al di fuori delle logge. Come noto, ogni massone può dichiarare se lo è, ma gli è vietato fare i nomi dei “fratelli”. Nathan li fece in tempi nei quali per le autorità di polizia spesso le logge erano considerate circoli rivoluzionari, perché davano asilo a estremisti e persino ad aderenti all'Internazionale.
Riscossa e ritrovata “fratellanza internazionale”
Nel 1899 il GOI dovette fronteggiare la crescente ostilità dei socialisti, che si aggiunse a quella, scontata, dei clericali e dei reazionari. Una contorta nota anonima della “RMI”, da attribuire a Ulisse Bacci, suo direttore-proprietario, confutò la “strana teoria” dell'“Avanti”, schierato a fianco dei dissidenti contro il GOI: «Si vorrebbe, forse, che tutte le forze massoniche cospirassero a radicali mutamenti nelle istituzioni pubbliche, che a quello intento unicamente si tendesse senza preoccuparsi delle conseguenze che, date le condizioni attuali del paese, potrebbero derivarne. […] A noi sembra – concluse – che prima di essere dinastici, monarchici, moderati, progressisti, radicali, socialisti, repubblicani, si debba essere patriotti.» Come lo erano i massoni nei rispettivi Stati e come Ernesto Nathan ribadì nella Relazione sul triennio di gran maestranza scritta in vista della gran loggia convocata in Roma per il 26 novembre 1899. Dal 1896 – osservò Nathan – il numero delle logge e dei fratelli attivi e quotizzanti non era cresciuto, però l'Istituzione aveva retto alla scissione e molti vecchi iniziati si erano ridestati dal sonno, tornando operosi con energie giovanili. Passata la tempesta, tempo era venuto di vita nuova. Lo si vide, appunto, nella prima metà del 1900, con la costituzione di logge in terre che ne mancavano da decenni. Anche quale stimolo per i “fratelli”, la “RMI” dette ampio spazio all’installazione di nuove officine. Fu il caso della “Propaganda massonica” di Torino, di Rito scozzese, costituita il 30 gennaio e destinata a raccogliere fratelli dall'intero Piemonte, ove molte province non contavano neppure una loggia. Lemmi le rivolse un saluto nel quale orgogliosamente ricordò la propria opera: «Quel poco che io feci per risollevare l'Ordine dalla bassura in cui era caduto, per dargli a furia di lavoro febbrile, di inenarrabili sacrifici, unità organica e vigoria d'impulso civile, mi è largamente, dolcemente compensato nel vederlo oggi – mercé gli sforzi di tutti – considerato e potente […]. Bisogna lottare, perseverare, vincere.» Poi fu la volta della “Giuseppe Mazzini” di Sanremo, presenti “fratelli” accorsi da Genova, Sampierdarena, Savona, Ventimiglia e anche da Ginevra e da Nizza. La “RMI” salutò poi la fondazione della “Giuseppe Garibaldi” di Porto Maurizio, costituita con «elementi tutti nuovi […] qualche fratello disperso, un buon numero di profani scelti con prudenza e con acume fra la gioventù del paese animata da spiriti sinceri di progresso di libertà». La sua storia è analiticamente documentata dal robusto volume di Filippo Bruno, imperiese “portorino doc”, grado 33° del Rito, “La Riviera dei Framassoni” (La Spezia, ed. Il Filo di Arianna, 2025). Costituita poche settimane dopo la “Mazzini”, nella “RMI” la “Garibaldi” venne ricordata solo il 30 ottobre 1900, insieme con la “Risveglio Basso Ferrarese” all'Oriente di Copparo, nata per impulso di un nucleo di massoni della “Felice Foresti” di Ferrara, nuovo nome distintivo della “Gerolamo Savonarola”, e con la “Aurelio Saffi” di Forlì, installata con la partecipazione del deputato cuneese Tancredi Galimberti, all'epoca su posizioni radicaleggianti ma poi slittato sul fronte cattolico-moderato. Altrettanto significativa fu la costituzione della “Excelsior”, di rito simbolico, a Torre Pellice. Nella succosa cronaca dell'evento la “RMI” osservò che alla sua installazione parteciparono cinquanta “fratelli” giunti da Torino, nonché inglesi e americani, “villeggianti su quelle alture”, e il sindaco del capoluogo delle valli valdesi. Le logge liguro-piemontesi facevano dunque da ponte tra il Grande Oriente e le comunità liberomuratòrie di altri Stati e mandavano un segnale importante di fratellanza universale proprio mentre si sentivano rullare tamburi di guerra. È significativo che le nuove officine liguri venissero intitolate a due tra i massimi protagonisti del Risorgimento e dell'unificazione nazionale. Mazzini e Garibaldi furono scelti quali nomi distintivi benché fossero note le divisioni che dal 1856 li avevano condotti su posizioni via via più inconciliabili, con ricadute polemiche sui rapporti tra i rispettivi seguaci. Era un mònito a non indulgere ai particolarismi. Nathan, dunque, reagì alla scissione, dolorosa per il rango massonico, politico e civile dei dissidenti, promuovendo l'accensione di nuove luci nell'Italia nord-occidentale e sempre con la rappresentanza di “fratelli” d'Oltralpe. Constatata la consistenza del Grande Oriente Italiano, attenuò i toni della polemica anche per riaprire il dialogo con logge del GOF. La ferita venne risanata dopo le sue forzate dimissioni da gran maestro (1903) e l'elezione di Ettore Ferrari. A guarirla provvidero giovani in parte massoni e in altra parte no, ma sicuramente amici di “fratelli”. Un ruolo eminente ebbero il canavese Efisio Giglio-Tos e i consolati della “Corda Fratres”, Federazione studentesca internazionale promossa nel 1898, dal 1900 diffusa in tutta Italia e vivaio della classe dirigente del nuovo secolo, grazie a giovani di ampie vedute come Angelo Fortunato Formiggini. Tra le sue prime iniziative vi furono il Congresso dei “cordafratrini” a Parigi (studenti e, va sottolineato, studentesse), in occasione dell'Esposizione universale del 1900, e una fitta serie di convegni universitari italo-francesi al di qua e al di là delle Alpi, a cominciare dalla garibaldina Nizza. Era il segnale di cui v'era bisogno per ricomporre il dialogo tra le Massonerie “latine”. Il 125°della “accensione del fuoco” della “Giuseppe Mazzini”, come, poco dopo, della “Giuseppe Garibaldi” di Imperia, documenta che quell'Italia era Europa dal Settecento: un universo di “uomini liberi” che lasciavano alle spalle le guerre per motivi religiosi, razziali e ideologici. Anticipavano i princìpi scritti nella Costituzione italiana e oggi considerati “normali”. Ma all'epoca, come nei due secoli successivi, condividerli e viverli costava scomuniche, persecuzioni, condanne e in qualche caso anche la vita. Il sofferto cammino dei “fratelli” d'Italia va ricordato cent'anni dopo la “legge fascistissima” che nel maggio-novembre 1925 costrinse al silenzio le comunità massoniche italiane. Riemersero nel 1944-1945. Tra i suppliziati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 si contarono almeno venti massoni, tra i quali Placido Martini, gran maestro designato del GOI. Nell'80° della “Liberazione” meritano memoria.
Aldo A. Mola
DIDASCALIA. La copertina di “I guardiani della Nuova Italia. La Loggia Giuseppe Mazzini di Sanremo dall'Ancien Régime alla modernità: eventi e personaggi” (ed. Leucotea), che viene presentato alle 10 di domenica 4 maggio al Teatro Centrale di Sanremo con interventi di Luca Fucini, Alessandro Cecchi Paone, Marzia Taruffi e altri. Per approfondimenti v. Luca Fucini-Roberto Colombo, “Sanremo e la Massoneria”, Sanremo, Circolo filatelico numismatico sanremese, 1997; Luca Fucini, “Misteri e segreti della Massoneria a San Remo”, Antea, 2010; “La Massoneria nel Potente Ligure”, Antea, 2023. Sulla “Corda Fratres” v. A. A.Mola, “Corda Fratres. Storia di un'associazione internazionale studentesca”, pref. di Fabio Roversi Monaco, Bologna, Clueb, 1998. Di fondamentale importanza è infine “La Riviera dei Framassoni” di Filippo Bruno 33.'. (La Spezia, Il filo d Arianna, 2025, pp.541), panorama documentatissimo di tre secoli di logge del Ponente Ligure.